Dal vertice di Salonicco all’Open Balkan, vent’anni di promesse, annunci e veti incrociati nella sala d’attesa d’Europa. Il conflitto russo-ucraino ha riaperto i dossier d’integrazione all’Ue dei Balcani occidentali, ma l’oriente è sempre più vicino
L’ultimo capitolo, solo in ordine di tempo, è stato scritto: Macedonia del Nord e Albania possono iniziare i negoziati di adesione all’Ue.
Lo sblocco dell’impasse è stato possibile grazie all’approvazione del Parlamento macedone e bulgaro della proposta di mediazione francese, utile a superare il veto di Sofia all’avanzamento del dossier (condiviso con l’Albania) per via delle dispute identitarie con la Macedonia del Nord.
Per i meno attenti alle questioni balcaniche, la saga che vede protagonisti Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e la loro integrazione all’Unione europea, è un’avvincente racconto sintetizzabile con le parole di Winston Churchill: i Balcani producono più storia di quanta ne possono digerire.
Due decenni di protagonisti, comparse e assenti ingiustificati. Testimonianza dei tentativi di arginare e compensare i ritardi con cui l’Unione Europea sta dando riscontro alle ambizioni della regione. Unita alla reale capacità dei Balcani di perseguire degli obiettivi di adeguamento, stretti tra la volontà di alcuni, di elevarsi al rango di paese comunitario e l’interesse di altri, di mantenere lo status quo in un’ambigua posizione geopolitica.

L’invasione russa dell’Ucraina ha riacceso il dibattito sopito sull’allargamento dei confini comunitari. Non è irragionevole aspettarsi un deciso cambio di marcia nelle contrattazioni, tuttavia lo stallo degli ultimi vent’anni consiglia più cautela che facili entusiasmi.
L’Ue mostra ancora i segni di un assoggettamento alla politiche nazionali, evidenziando storiche fragilità che rischiano di ampliare le distanze, sia in termini di consenso che di riforme sostanziali.
Tuttavia deve fare i conti con società multietniche che presentano ancora importanti deficit legati a libertà, corruzione sistemica e fiducia nella democrazia. Terra fertile per i leader populisti, attori dello status quo che a giro si servono di interferenze straniere come pungolo per dimostrare che un alternativa c’è sempre.
Candidati e veti incrociati (fuoco amico)
«Il futuro dei Balcani è nell’Unione Europea. Per i paesi dei Balcani occidentali l’allargamento in atto e la firma del trattato di Atene nell’aprile 2003 sono motivo di stimolo e di incoraggiamento a percorrere lo stesso positivo cammino. […] La rapidità dei progressi è nelle mani dei Paesi della regione».
Era il giugno 2003 e a Salonicco, con la firma di una comune dichiarazione di intenti, si chiudeva lo storico Consiglio europeo che definiva formalmente la prospettiva di adesione all’Unione Europea dei Balcani.
Per i Paesi della ex Jugoslavia si apriva il primo spiraglio di luce dopo decenni di autoritarismo e conflitti intestini.
In Europa c’era grande entusiasmo: era entrata in circolo la moneta unica e di lì a poco il processo di allargamento avrebbe compiuto una svolta epocale con l’adesione in blocco delle ex repubbliche sovietiche.
La prospettiva di una vicina integrazione all’Ue costituiva il principale incentivo alla pacificazione e alla stabilizzazione dell’intera regione.
Slovenia e Croazia riuscirono ad aprire una breccia. La prima potè entrare nel più ampio contesto dell’allargamento a est nel 2004; la seconda, dopo intensi negoziati ebbe luce verde nel 2013. Croazia che, con il recente via libera della Commissione europea, dal primo gennaio 2023 farà anche il suo debutto nell’Eurozona, divenendo il ventesimo Paese dell’Ue ad adottare la moneta unica.

Con l’avvio dei negoziati, Macedonia del Nord ed Albania raggiungono Montenegro e Serbia, in sala d’attesa rispettivamente dal 2012 e dal 2014. Mentre la Bosnia-Erzegovina è ferma alla domanda di adesione del 2016 e il Kosovo alla firma di un accordo di stabilizzazione e associazione raggiunto nello stesso anno.
Col passare degli anni l’eccitazione iniziale è stata sostituita da una ‘balkan fatigue’, con un’integrazione che procede a rilento e un sempre più diffuso malcontento popolare nei confronti delle istituzioni europee e di quei paesi che a più riprese hanno ostacolato questo processo.
Si ricorda il caso della Slovenia che nel 2008 pose il veto all’entrata della Croazia per le controversie inerenti al confine nella baia di Pirano. Il 2016 è la volta della Croazia che blocca l’avanzamento della Serbia, aprendo un contenzioso sulla salvaguardia delle minoranze croate in territorio serbo e l’abolizione della legge sulla giurisdizione dei crimini di guerra. Una norma che permette alle corti serbe di giudicare i crimini commessi negli anni ‘90 su tutto il territorio della ex Jugoslavia.
Discorso a parte merita la Macedonia del Nord, vero e proprio pomo della discordia. Per decenni bloccata dalla Grecia per la disputa sul nome, solo quattro anni fa è riuscita a firmare un accordo (Accordo di Prespa), abbandonando la vecchia denominazione in contrasto con l’omonima regione greca.
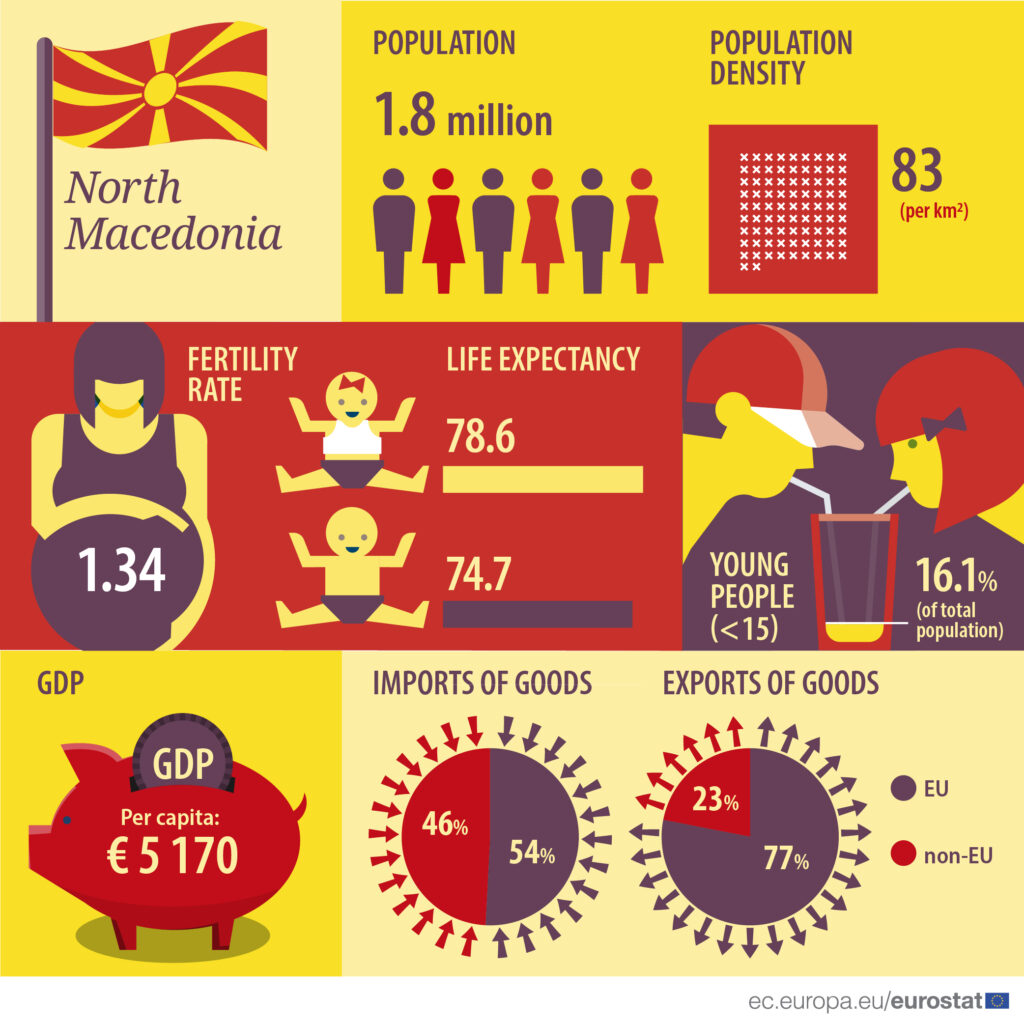
Altro fuoco amico arrivò nel 2019 da Francia, Paesi Bassi e Danimarca: un veto all’apertura dei negoziati che toccò anche l’Albania, volto a una maggiore cautela nell’allargamento ai paesi considerati ‘complessi’, onde evitare il ripetersi di ribellioni e ricatti in stile orbaniano.
Più di lunga data le controversie aperte dalla Bulgaria nei confronti di Skopje: i due paesi condividono radici linguistiche e culturali, ma hanno opinioni diverse sulla ragioni storiche. La Bulgaria non riconosce l’esistenza di una lingua macedone, retrocessa a puro dialetto bulgaro e i documenti storici differiscono persino sulla provenienza dei rivoluzionari che entrambi celebrano come eroi nazionali.
Nel 2017 i due Paesi firmano un trattato di amicizia per archiviare le rivendicazioni, garantendo a entrambi la propria visione storica e l’impegno a tutelare le minoranze, ma passata l’euforia Sofia ha più volte lamentato i pochi progressi fatti come uno dei motivi del proprio veto all’integrazione dei macedoni.
Tale vicenda suggerisce come le contrattazioni con l’Ue, con le norme vigenti, possano essere prese in ostaggio in qualunque momento.
In Albania la corruzione e la criminalità organizzata rimangono problemi seri e l’intreccio di politica, economia e media inibisce lo sviluppo di un’informazione veramente indipendente. Nonostante questo gli sforzi nell’ammodernamento delle infrastrutture e gli investimenti di piccole e grandi imprese hanno determinato una forte crescita economica, dando slancio alle ambizioni europee del Paese.
Lo sblocco del dossier macedone ha ufficialmente aperto i negoziati con l’Ue, ma lo spettro dei veti è sempre dietro l’angolo. Sebbene Tirana non sia stata bersaglio dei suoi vicini, in fase di negoziazione la Grecia potrebbe riaprire la storica controversia relativa ai confini marittimi.
A maggio i ministri degli Esteri dei due Paesi hanno promesso che affideranno alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia la risoluzione della delimitazione della piattaforma continentale e delle zone economiche esclusive ZEE. Una disputa lunga anni che recentemente ha avuto una decisa accelerazione.

Atene punta a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo (vedi gli accordi del 2020 con Italia ed Egitto sulla demarcazione dei confini e delle Zee) a causa del crescente attivismo della Turchia che mira a ritagliarsi un ampia fetta sul passaggio dei futuri oleodotti e gasdotti che trasporteranno energia proveniente dai giacimenti nel Mediterraneo. Tirana dalla sua, spera di usare la Grecia per ammorbidire i Paesi ancora restii alla sua entrata in Ue, giocando anche la carta Ankara e le sue basi militari per mettere maggior pressione.
Con l’apertura dei negoziati Ue-Albania, la Grecia potrebbe far valere il suo potere di veto e scrivere un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali.
Per la Bosnia-Erzegovina invece, il più grande ostacolo proviene da se stessa.
Il leader della Repubblica Srpska Milorad Dodik, ha riacceso una pericolosa retorica separatista che rischia di inasprire il delicato equilibrio tra le tre etnie (bosgnacca, croata e serba) che governano la tripartita Federazione.
A nulla è valsa la spinta alla candidatura presentata nell’ultimo Consiglio europeo dalla Slovenia, con il sostegno di Austria e Croazia. Una richiesta ancora difficile da esaudire, ma sintomo di un’urgenza, del bisogno di mosse concrete che non lascino spazio ad un nuovo terreno di conflitti.
E poi c’è il Kosovo. L’Ue lo considera nell’orbita europea, ma i quasi 2 milioni di abitanti si trovano a fare i conti con il mancato riconoscimento di Stato indipendente da 5 Paesi dell’Unione (Spagna, Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia) e l’impossibilità di muoversi oltre i confini nazionali senza un visto. Secondo l’Henley Passport Index, l’istituto che esamina la posizione di un passaporto nella mobilità globale, il Kosovo è al 104esimo posto su 112, un gradino sopra la Corea del Nord.

Il tira e molla con la Serbia non facilita la situazione. L’ultimo attrito con la “guerra delle targhe”, scoppiata dopo che Pristina ha imposto alle auto con targa serba (rilasciate da Belgrado agli abitanti del nord del Kosovo in maggioranza di etnia serba), di esporre etichette con la dicitura ‘Repubblica del Kosovo’, in risposta a un obbligo di Belgrado che dal 2011 prevede sul proprio territorio l’adozione di targhe provvisorie per i mezzi provenienti dal Kosovo.
Lo scorso 27 giugno il governo di Pristina ha annunciato che tutti i veicoli con targhe rilasciate dalla Serbia dal 10 giugno 1999 al 21 aprile 2022, avranno tempo fino al 30 settembre per ottenere la nuova targa kosovara. Un termine oltre il quale scatterà il blocco. Una scelta che scatenato le barricate dei cittadini e l’uso di polizia armata ai valichi di frontiera.
Con un tale livello di instabilità sarà difficile parlare concretamente di Europa nei Balcani occidentali. E non importa quanto uno eccelle in classe, il rendimento dei compagni potrà sempre essere un freno.
Ne è un esempio il Montenegro che, dall’indipendenza del 2006, ha compiuto passi da gigante entrando a far parte del WTO, membro della NATO dal 2017 e front-runner dell’integrazione Ue. Eppure il paese è ancora in sala d’attesa.
In contrasto con i suoi successi di politica estera, il Montenegro fa i conti, tanto quanto i suoi vicini, con l’innegabile difficoltà a superare quello che viene definito ‘state capture’, fatto di un endemica corruzione politica. Non è un caso che nel processo di adeguamento all’Ue, i capitoli più delicati rimangono la giustizia, la libertà e la sicurezza.
In più, sul fronte interno il partito di governo ha sempre agito come unico depositario del processo, relegando l’intera società a puro soggetto passivo.
Protagonista indiscusso è Milo Đukanović, ex compagno al fianco di Milošević che, grazie al suo trasformismo politico, è riuscito a costruire un piccolo regno sfruttando le divisioni etniche tra serbi e montenegrini.

Il nuovo corso avviato nel 2020 ha segnato la prima transizione pacifica del potere dopo 30 anni di governo monopartitico. Naturalmente nessuno si aspetta cambi epocali nel breve termine, la difficile costruzione di maggioranze parlamentari solide ne è un esempio, ma nel giovane primo ministro Dritan Abazović, un classe ’85 di etnia albanese che ha ottenuto la fiducia del Parlamento lo scorso 28 aprile, sono riposte le speranze di un’intera generazione.
Ciò che non ha subito dure sterzate è l’orientamento in politica estera. Nonostante la presenza di partiti filo-serbi e la loro parentesi di governo, il Paese ha sempre mantenuto una linea atlantista con prospettiva europea. Lo confermano le sanzioni economiche nei confronti della Russia, avviate nel 2014 e rinnovate dopo l’invasione del 24 febbraio e le accuse al Cremlino di aver sponsorizzato un tentativo di colpo di Stato nel 2016, per impedire l’adesione alla NATO. Ma nell’attuale congiuntura nulla può esser dato per scontato.
La storica presenza russa sul territorio suggerisce cautela. Basti pensare al rapporto della Banca centrale del Montenegro, secondo cui i russi sono i maggiori acquirenti di immobili del Paese (per anni definito il villaggio vip russo), in aumento dall’invasione dell’Ucraina, seguiti da Emirati Arabi Uniti e Turchia.




